La parola jazz deriva dallo slang americano dei primi del ‘900. Forse da jasm, usato per indicare
uno spirito combattivo o da jass la musica delle comunità nere.
1 aprile 2025 – Aldo Carioli
La parola jazz ha origini incerte, ma sappiamo che deriva dallo slang americano dei primi del
Novecento. Forse da jasm, usato nel XIX secolo per indicare energia, vitalità o spirito combattivo.
Un’altra ipotesi collega il termine jazz a espressioni usate dai musicisti afroamericani di New
Orleans, dove questo genere ha avuto origine.
MUSICA NERA? Nei primi anni del Novecento la parola, che veniva anche scritta jass, fu associata
alla musica delle comunità nere, portata al successo commerciale da band bianche. La prima incisione
di un brano jazz si deve infatti a un quintetto di musicisti bianchi (tra cui due italo-americani),
la Original Dixieland Jass Band One-Step, che nel 1917 registrò Livery Stable Blues per la Victor
Talking Machine Company.
UNO STILE UNICO. È forse il contributo più autenticamente made in Usa alla cultura musicale, anche
se le sue origini sono africane. E si riconosce al primo ascolto. Il jazz, con il blues al quale è
strettamente legato, ha infatti caratteristiche tecniche che lo rendono unico rispetto ad altri
generi.
IMPROVVISAZIONE. A partire da una melodia e da una struttura armonica prestabilita, i musicisti jazz
sviluppano variazioni e nuovi intrecci, creando ogni volta una versione personale del brano. Per
questo nel jazz si usano gli “standard”, canzoni famose che ogni musicista (e ogni generazione)
rivisita con il proprio stile. Negli anni Venti nacquero le jam sessions, incontri fra diversi
musicisti che si trovavano su un palco appunto per suonare improvvisando. Le improvvisazioni nelle
jazz band tradizionali avvengono “a turno”.
SCHEMA BAROCCO. In origine si seguiva lo schema “call and response”, derivato dalla musica
tradizionale africana: un cantante “lancia” o “chiama” (call in inglese) una melodia alla quale
risponde (response) il gruppo. L’improvvisazione però non l’hanno inventata i jazzisti: già nella
musica barocca del XVII e XVIII secolo si lasciava grande spazio alla libera invenzione di
strumentisti e cantanti.
SINCOPATO E SWING. L’altro elemento che fa riconoscere al primo ascolto un brano jazz è il ritmo.
Qui regna il “controtempo”. In un brano in quattro quarti (1-2-3-4), l’accento ritmico non cadrà sul
primo e sul terzo tempo, come di solito nella musica classica o in molte musiche tradizionali, bensì
sul secondo e sul quarto. Da qui l’importanza della sezione ritmica: batteria, contrabbasso (ma
anche pianoforte). Lo shuffle, cioè l’uso di accentuare la prima e la terza nota in una terzina
(gruppo di tre note) crea invece l’effetto di “ritmo spostato” tipico del blues e dello swing.
BLUE NOTES. Le “note blu” sono un’altra eredità del blues, ma nell’armonia: alcune note (la terza,
la quinta e la settima della tonalità nella quale si sta suonando) vengono abbassate di mezzo tono
rispetto a quanto previsto dalle regole dell’armonia classica. Un accorgimento che trasmette al
nostro cervello il senso di “malinconia” (blue mood) associato al blues e al jazz.
NUOVE FRONTIERE. Con gli anni, soprattutto tra i Quaranta e Cinquanta del Novecento, il linguaggio
jazz è diventato più complesso: poliritmia (sovrapposizione di più ritmi in uno stesso brano); scale
“modali” basate su una sequenza di intervalli diversa da quella delle abituali scale tonali;
superamento della struttura del blues (12 battute) e della forma AABA, tipica degli “standard”
americani, dove la sezione A è il tema principale (ripetuto due volte) la B è il secondo tema e
l’ultima A il ritorno del tema principale. Fino all’improvvisazione totale e collettiva del free
jazz anni Sessanta.
da focus.it
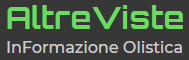
Lascia un commento